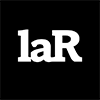Vincenzo e il suo ‘esercizio di libertà’
Un utente della Casa don Orione di Lopagno ha percorso la via Francigena per 150 km aprendo la strada a chi spesso viene considerato limitato
Di Malva Cometta Leon
«Con Vincenzo abbiamo imparato la grammatica del passo lento. Il suo fermarsi, guardare, respirare, contemplare i prati fioriti ci ha insegnato che il traguardo non è mai un punto sull’asfalto. È un fragile equilibrio tra fatica e presenza. Tra sforzo e compagnia. Ci ha fatto capire che, a volte, arrivare non è “arrivare prima”, ma arrivare bene». Le parole di Davide Daniele, responsabile della struttura Casa don Orione di Lopagno, ci introducono nell’avventura vissuta ad aprile da un utente con disabilità lungo la via Francigena. Un cammino che per Vincenzo è stato un’esperienza tramutatasi in un «esercizio di libertà».
«È stata la prima volta che ho percorso così tanti chilometri a piedi. Sono felice di poter condividere con il mondo questo traguardo», ci dice emozionato. Da Bolsena a Roma sono poco più di 150 chilometri. «165,9», precisa, perché non vuole tralasciarne nessuno. Tutti lo hanno arricchito. Ad accompagnarlo, passo dopo passo, Daniele con suo padre Antonio, Nicoletta Moser
Maffioli, vegliatrice della struttura, Claudia Cotta, curatrice di Vincenzo da molti anni con sua sorella Loredana. Sei persone con storie, limiti, forze e desideri differenti, che insieme hanno saputo trasformare la fatica in dialogo, la lentezza in relazione. Le strade antiche di quella tratta della via Francigena «hanno aperto possibilità nuove a chi spesso viene considerato “poco mobile” – racconta Daniele – nelle scelte, negli spazi e nell’autonomia. Su quel sentiero tutti noi abbiamo potuto dimostrare qualcosa: chi accompagnava e chi veniva accompagnato». Perché, afferma, «l’autonomia non è una conquista solitaria, è un risultato collettivo».
Sette giorni, cinque tappe
Un gruppo «improbabile solo all’apparenza, in realtà, perfetto per affrontare fatica, lentezza e silenzi, senza fretta, senza maschere, senza pretese». Un sodalizio che ha deciso di proporre a Vincenzo quest’esperienza e di viverla insieme a lui nel proprio tempo libero. Così, il 25 aprile, con il sacco in spalla e tanto entusiasmo, sono partiti. Sette giorni di cammino, 5 tappe e circa 20 chilometri al giorno. Bolsena, Montefiascone, Viterbo, Vetralla, Sutri, Campagnano, La Storta, il Vaticano di Roma. Ma di tutti questi luoghi, a Vincenzo ne è rimasto impresso uno in particolare. «Vicino a Viterbo abbiamo visto un prato fiorito meraviglioso. Mi è piaciuto talmente tanto che ho voluto dipingerlo su dei quadri. Mi è proprio rimasto nel cuore». Immersi nella natura, «facevamo 20-30mila passi al giorno, il contapassi di Vincenzo non si sa perché ma ne contava sempre di più», ride al ricordo Moser Maffioli. «Ogni mattina partivamo presto», racconta Daniele. «Troppo presto», commenta Vincenzo. Le prime ore, continua il responsabile, «erano sempre una trattativa con le gambe e con il fiato: “Ce la faremo oggi?”. “Ci saranno salite?”. “Sarà dura?”. Poi, quasi senza accorgercene, smettevamo di discutere con noi stessi e iniziavamo semplicemente a camminare. E il passo diventava la nostra unica misura. È così che si procede nella vita, crediamo. Un passo, poi un altro. Senza sapere bene quanto manca ma sapendo che ogni metro conta». Ogni giorno poi lo scambio con altri viaggiatori. «Abbiamo avuto la fortuna di conoscere un po’ di persone interessate alla nostra storia e che si sono unite a noi per una parte del percorso».
E poi c’era lo zaino con il suo peso. «Ne parlavamo spesso, quasi fosse un altro compagno di cammino. Credevamo di aver preso l’essenziale. E invece, come succede nella vita, ci trascinavamo dietro molto di più: cose che non servivano davvero, pensieri superflui, paure, preoccupazioni. Camminare ci ha ricordato che viaggiare leggeri non vuol dire rinunciare, ma scegliere. Decidere cosa ha valore e cosa no». E alla fine di ogni giornata di cammino, «ci sentivamo orgogliosi di avercela fatta. Il bello di questo cammino è che ti fa capire che puoi farcela». E a premiare i viaggiatori sulla traccia dei pellegrini, un pasto caldo negli ostelli, conventi o rifugi che li ospitavano. «La sera, davanti a un piatto pieno di sapori della terra attraversata (e di cucina laziale), tutto diventava chiaro. Il cibo era una ricompensa, un abbraccio. Era il modo più semplice e vero per dirci: “Oggi abbiamo fatto qualcosa di grande”». A testimoniare il loro passaggio, i timbri sul passaporto del pellegrino. «Un prezioso ricordo», ci dice Vincenzo mostrandoci con fierezza il documento.
‘Non c’è arrivo senza cambiamento’
Il 3 maggio, Roma è comparsa in lontananza. «Mi sono quasi commosso», confessa. «Non è stato solo un arrivo – aggiunge Daniele -. È stato un silenzio pieno, un “trionfo tranquillo”. Avevamo gambe stanche e una leggerezza nuova dentro. Come se la strada avesse tolto peso, non aggiunto». E poi il ritorno a casa. «Tornare è stato strano. Tutto era al suo posto, ma niente si riconosceva più del tutto. I luoghi erano gli stessi, ma noi li guardavamo con occhi diversi. Gli oggetti erano immobili, ma noi ci muovevamo con un passo nuovo. Ritornare non è mai una questione di geografia. È fare spazio tra ciò che resta e ciò che siamo diventati. Abitare il conosciuto con una consapevolezza diversa. Capire che un ritorno non è un passo indietro. È un passo dentro. Dentro una pelle nuova, dentro una vita che non chiede di cancellare le strade percorse, ma di integrarle. Forse il senso del cammino è proprio questo: non c’è arrivo senza cambiamento. E il vero traguardo è diventare qualcuno che sa tornare diverso». Un ulteriore dono maturato da quest’esperienza sulla via Francigena è la voglia di ripartire, di continuare a fare questi «esercizi di libertà». Infatti, ci comunicano, per l’anno prossimo «abbiamo una nuova meta: contiamo di andare a Santiago di Compostela, “il cammino dei cammini”. Vorremmo percorrere il Cammino inglese, da Ferrol a Santiago. Roma è stata solo una tappa. Noi ci siamo. Pronti a ripartire. E forse ci accompagnerà anche un altro utente».
È stata la dottoressa Gea Silvia Sofia Cereghetti, quest’anno, a ricevere il riconoscimento della Fondazione Cesare e Iside Lavezzari. Il premio massimo, anno 2025, giunto alla sua cinquantanovesima edizione, è stato attribuito alla giovane, nata a Mendrisio e cresciuta a Morbio Inferiore. A motivarlo “la sua eccellente capacità di giovane ricercatrice ‘momò’, assurta a chiara fama internazionale, in virtù dei significativi traguardi raggiunti, nel comprendere nell’ambito delle malattie neurodegenerative, dapprima i meccanismi delle patologie legate all’invecchiamento (Alzheimer e Parkinson), e quindi sviluppare soluzioni innovative per contrastarle, oltre che per l’impegno sul tema della resistenza agli antibiotici”. La cerimonia di consegna ha avuto luogo ieri in mattinata al Cinema Teatro di Chiasso alla presenza anche delle autorità cittadine.
Riconoscimenti per l’anno scolastico 2024/2025
Inoltre, la Fondazione ha assegnato i premi per l’anno scolastico 2024/2025 a Federica Audrino di Coldrerio, che al Liceo di Mendrisio ha ottenuto la miglior maturità in assoluto con il 6 di media. Premiati pure Giulia Camponovo (S. Pietro), che ha ottenuto una media del 5,8 alla maturità professionale al Centro professionale sociosanitario medicotecnico a Lugano, e Jeanne Canevascini (Novazzano), uscita anch’essa con la maturità professionale dal Centro sociosanitario di Lugano con la media del 5,8.
LUGANESE / MENDRISIOTTO
it-ch
2026-01-19T08:00:00.0000000Z
2026-01-19T08:00:00.0000000Z
https://epaper.laregione.ch/article/281685441245045
Regiopress SA