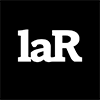La parabola di ‘The Bear’ dalla tachicardia allo zen
Una serie sul cambiamento che è cambiata troppo. Ma rimangono le scene familiari, i piatti meno prelibati, l’uso della colonna sonora, e Chicago
di Daniele Manusia
‘The Bear’ è morto, viva ‘The Bear’. Nel senso: è finita una delle serie più amate e celebrate dalla critica negli ultimi anni. Dal pubblico, un po’ meno. Perché ‘The Bear’ è cambiato e, anche se a parole dicono tutti l’opposto, la verità è che alla maggior parte delle persone i cambiamenti non piacciono. Se è difficile accettare che il proprio o la propria partner si tagli i capelli senza preavviso, o persino che si metta a dieta stravolgendo le abitudini alimentari di casa, figuriamoci se va bene che una serie cominciata per far venire la tachicardia a chi la guardava è finita a parlare di giardini zen, di rocce lontane e della sabbia che le unisce. In breve, per chi avesse bisogno di un riassunto: la prima stagione di ‘The Bear’ parlava del ritorno a Chicago di Carmy, giovane cuoco di talento, forgiato nella cucina del – letteralmente – miglior ristorante al mondo e completamente traumatizzato. Tornava per rinnovare e risollevare il ristorante del fratello maggiore, morto suicida, scontrandosi con lo staff che è sopravvissuto al fratello, tutta gente abituata a fare panini con la carne mandandosi a farsi fottere da una stanza all’altra senza paura di fare brutta figura davanti ai clienti. Quattro stagioni dopo in quello stesso locale, quello stesso staff, mette in scena una nevicata artificiale in piena estate per permettere a una ragazza venuta da fuori Chicago di gustarsi la cioccolata calda coi marshmallow come fosse Natale.
Un successo forse più per l’estetica che per la trama
Doveva finire dopo la prima stagione, la serie non era pensata per continuare, anche se il finale manteneva la porta aperta a ogni possibile sviluppo. È stato il successo improvviso e forse imprevisto avuto – dovuto forse più all’estetica che alla trama, ai sandali di cuoio coperti davanti, alle tshirt bianche con le maniche corte arrotolate sui tatuaggi da hipster, alla bellezza fredda e tormentata di Jeremy Allen White, improvvisamente diventato l’attore più fico del pianeta – ad aver fatto pensare ai dirigenti di Fx, che la producevano: sai che c’è, andiamo avanti. Quindi, in un certo senso, se la prima stagione di ‘The Bear’ era il piatto principale, mettiamo un’ottima amatriciana, bella ricca, pesante, saziante, le successive stagioni sono le macchie di sugo che ti restano sulla maglia. La seconda ha rallentato bruscamente, se non proprio frenato. Il pubblico si è trovato di fronte a una serie in cui succedevano poche cose, con episodi antologici costruiti su flashback intimistici.
La panineria è diventata un ristorante pretenzioso, lo staff di cafoni si è tirato a lucido e, nella terza stagione, Carmy si è addirittura innamorato. Trovando una specie di serenità che ha subito sabotato, perché altrimenti la serie sarebbe finita. Salvo poi chiedersi, appunto, perché abbia sabotato la sua stessa felicità. Alla fine di quattro stagioni Carmy si guarda attorno e capisce di essere rimasto l’unico personaggio della serie a soffrire senza motivo. Non che, grazie a questa presa di coscienza, riesca a muoversi in una direzione più sensata. Anzi. Questo è il più grande buco narrativo di ‘The Bear’, una serie minimalista e attenta ai dettagli, che cerca di dare profondità ai personaggi con poco, che però ha lasciato che il proprio protagonista restasse un mistero, l’unico incatenato alla propria autodistruttività. Non sappiamo perché Carmy non si lasci andare con Claire, sta quasi sempre zitto e quando parla non capiamo quello che dice, quanto non lo capiscono gli altri personaggi della serie, e fino alla fine (senza spoiler) è difficile interpretare le sue decisioni, che ci arrivano come semplici colpi di scena drammatici. Chissà, magari dopo quattro stagioni Christopher Storer, l’ideatore e autore della serie, si è reso conto che il suo protagonista, il classico eroe romantico bello e dannato, in fin dei conti era semplicemente un coglione.
Nel frattempo, mentre Carmy si lecca le ferite, smette e ricomincia a fumare, fa lunghi silenzi e poi grida cose senza senso a persone che lo guardano come se fosse un quadro astratto, il tema della serie è diventato la ricerca della felicità e dell’eccellenza da parte di tutti gli altri personaggi. L’attenzione piano piano si è spostata sulle vite di Terry, la cuoca latinoamericana a cui spettano le perle di saggezza migliori, su quella del nuovo Richie precisino e riflessivo, e soprattutto su quella di Sidney, la cuoca afroamericana che di fatto è una versione meno tossica ma altrettanto talentuosa di Carmy – interpretata da Ayo Edebiri, anche lei diventata in pochissimo una star. Ricerca della felicità, eccellenza non a discapito della salute mentale, pulizia interiore ed esteriore, come fare scelte sensate, come avere affetti profondi, come farsi domande quando si dà di matto, darsi le giuste priorità, fare meno, fare meglio: tutto il contrario di quello da cui ‘The Bear partiva’, una semplice serie sulla cucina come sport estremo e logorante. In effetti, a pensarci bene, è interessante che il pubblico abbia rimproverato a ‘The Bear’ di essere cambiata troppo, quando il tema principale della serie, è proprio il cambiamento.
E della stella Michelin chissenefrega
Per essere una serie più bella ‘The Bear’ sarebbe dovuta diventare una serie più semplice e banale, si sarebbe dovuta concentrare sui conflitti economici, sulle recensioni negative e positive del ristorante: riusciranno i nostri eroi a ottenere la famosa stella Michelin? Tutti sentieri già tracciati, che però un po’ per snobismo un po’ per raccontare altre cose ci sono stati solo mostrati da lontano. L’impatto di Jeremy Allen-White è diminuito, alla fine non è diventato il nuovo Tony dei ‘Soprano’ o il nuovo Don Draper di ‘Mad Men’, né tantomeno il nuovo Walter White o il nuovo Jon Snow, la sua figura si è rimpicciolita ed è scivolata sullo sfondo, sempre più sfocata. Forse anche concentrarsi sul protagonista maschio, bianco, bono, sarebbe stata una scelta troppo banale, forse persino datata, non al passo coi tempi.
Di ‘The Bear’, però, rimarrà tutto il resto. Le scene familiari: cene di Natale con macchine che sfondano la parete del salotto; matrimoni passati in dieci sotto al tavolo per convincere una bambina troppo timida per ballare col padre a venire fuori. Rimarranno i piccoli miglioramenti senza grande enfasi, né estetica monetizzabile, che sono costati fatica a personaggi come Tina o Ebrahim, che alla fine ha l’illuminazione di aprire dei piccoli franchise della panineria da asporto che Carmy ha mandato avanti in parallelo al suo ristorante. Rimarranno piatti meno prelibati come la pastaccia col sugo pronto che chef Sidney prepara alla nipote, il pollaccio che Carmy fa alla madre. Rimarranno gli occhi di Claire, quelli penetranti e profondi di Richie (Ebon Moss-Bachrach, forse il miglior attore di tutto il cast, dopo Jamie Lee Curtis). Rimarrà l’uso della colonna sonora – ‘The Bear’ è una serie da guardare con Shazam sempre aperto – e rimarrà Chicago: poche serie raccontano una città in particolare e ti danno voglia di prendere un aereo il giorno dopo. Alla fine la stella Michelin che sembrava così importante non è arrivata, ma chissenefrega. Di questo, forse, parlava ‘The Bear’.
CULTURE E SOCIETÀ
it-ch
2025-08-11T07:00:00.0000000Z
2025-08-11T07:00:00.0000000Z
https://epaper.laregione.ch/article/281822879876860
Regiopress SA